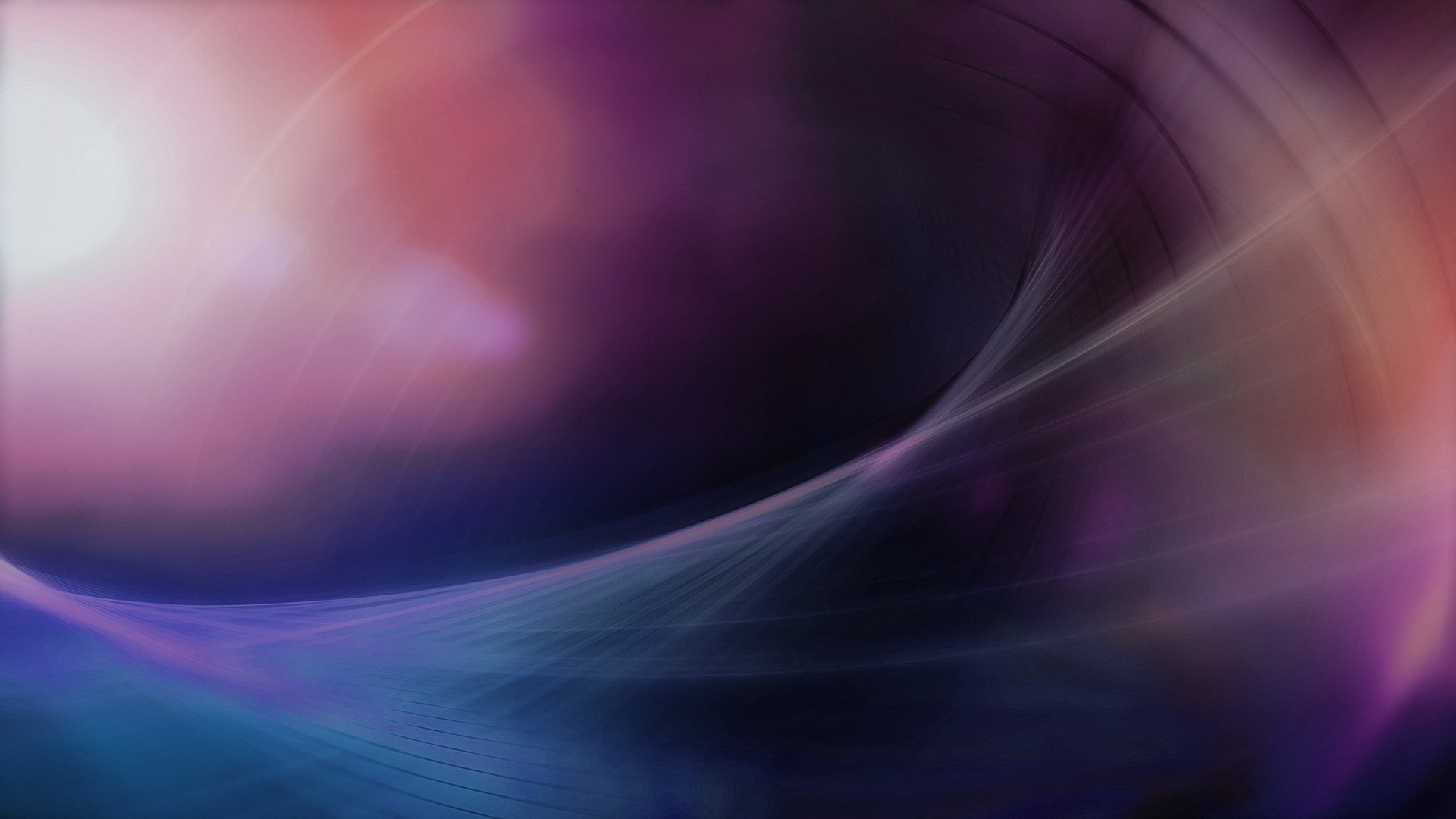da emanuele | Apr 18, 2023 | Articoli Insegnanti, asana, Hatha Vidya, Prana Vidya, Pranayama
Roberto Laurenzi – EFOA L’idea di curare malattie, disturbi e distonie con lo Yoga ha origine nell’India arcaica, quando le classi più disagiate risolvevano il problema della pensione, abbandonando i vecchi ormai inabili o malati nelle foreste, ove avrebbero...

da admin | Nov 4, 2022 | asana
La posizione dell’Arco è una posizione potente che agisce a livello fisico, pranico, mentale, spirituale e terapeutico. Inizialmente è sufficiente praticarla anche solo in fase dinamica per ottenerne incredibili benefici, ma il massimo si raggiunge quando la si...

da admin | Ott 28, 2022 | asana
Tecnica Posizione di partenza: Ci distendiamo proni, con le braccia lungo il corpo. Gambe unite, piedi uniti. Rilassiamo tutto il corpo, cercando di eliminare ogni tensione parassita. Abbandoniamoci completamente alla posizione, cercando di sentire la pesantezza del...
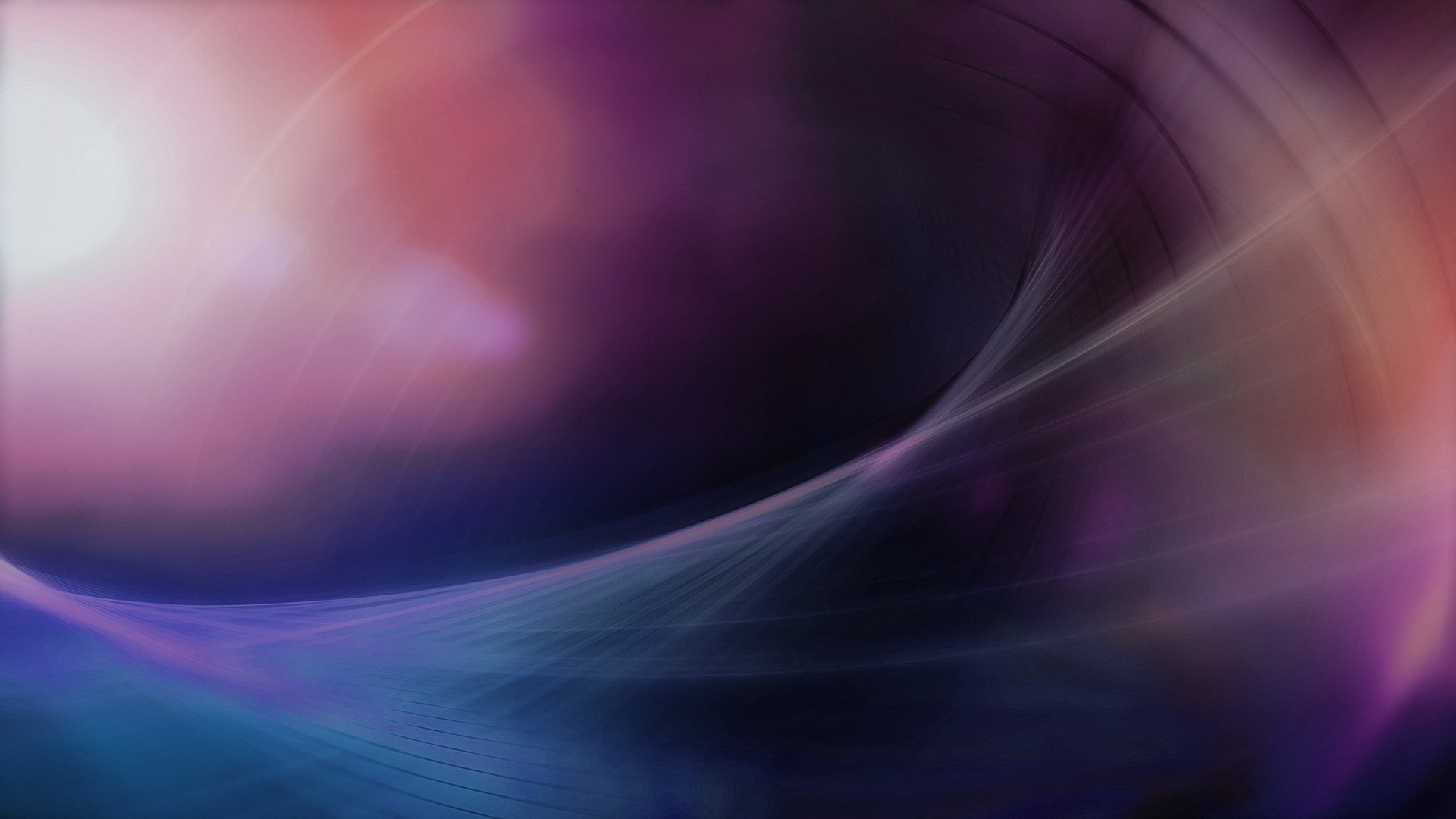
da Francoise Berlette | Set 16, 2020 | asana
di Laura Bonomini E’ appena terminata l’annualità di Pranayama in cui abbiamo imparato a governare e guidare il nostro respiro e la nostra forza vitale nel corpo. Attraverso volontà e intenzione mentale, il soffio del respiro, impregnato di Prana, ci purifica e cambia...

da Francoise Berlette | Ago 10, 2020 | asana
di Gaia Zanchini All’interno della pratica di Hatha Yoga sono molte le posizioni che richiedono al nostro corpo, e con esso alla nostra mente, di flettersi all’indietro. Anche la flessione all’indietro, come la sua antitesi (la flessione in avanti), ha una forte...

da Francoise Berlette | Ago 7, 2020 | asana
di Dania Bicchierai Una gestualità naturale I movimenti che compiamo nella vita quotidiana si realizzano quasi esclusivamente in avanti; proprio per questo motivo è estremamente importante utilizzare uno schema corretto di questo tipo di mobilità. Quando ci spostiamo,...